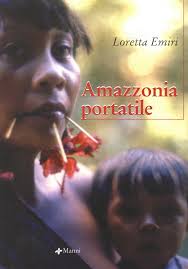—
Il viaggio nel mondo o il viaggio nell’Io?
—
di Tullio Bugari *
–
(Riflessioni stimolate dalla lettura del libro Amazzonia portatile, Loretta Emiri, Manni Editore, Lecce, 2003)
–
Durante l’estate ho letto il tuo libro, con un vero piacere e immersione, seguendo dentro il tuo racconto tutta la passione che vi hai messo.
–
Ho letto gran parte del libro mentre ero tra Palermo e Agrigento, soprattutto ad Agrigento, in un cortile chiuso e ventilato sulla punta più alta del centro storico, durante il mio breve giro estivo per la Sicilia occidentale. Il trovarsi comunque fuori dal proprio ambiente quotidiano (xurukurayu, per gli yanomami) rende più leggeri e, forse, favorisce anche il contatto con le suggestioni che ci creano le esperienze di altre persone e altri mondi, come se, paradossalmente, proprio quello spazio insolito, riuscisse a rendercele più familiari.
Come faccio al mio solito, ho letto il tuo libro in mezzo ad altri, credo in buona compagnia: la trilogia del marocchino Tahar Ben Jelloun, Creature di sabbia, Notte fatale e A occhi bassi; poi Origini del libanese Amin Maalouf, che ho trovato per caso in una libreria di Palermo, e per ultimo, del bosniaco Mesa Selimovic, Il derviscio e la morte, di cui anni fa avevo sentito parlare da una nostra amica preside di Mostar.
Come faccio al mio solito: nel senso che, essendo io che leggo, lo faccio con tutta la mia testa popolata in vario modo dalle cose che mi porto dentro. Così mi costruisco relazioni e associazioni di idee. Spero di non impegolarmi verso discorsi astrusi: speriamo bene.
Ho trovato una continuità di emozioni, quelle che si provano di fronte alla ricerca dei significati che stanno dietro alle nostre esperienze, con l’ostinazione di voler scoprire cosa ci lega davvero agli altri e al mondo, ma senza nessuna intenzione di volersi adattare troppo in fretta a ciò che appare. Anzi, cercando continuamente e con pazienza, e con quel po’ di saggezza che giorno per giorno nasce dall’esercizio di questa pazienza, il modo migliore di modellare non solo le nostre parole e i messaggi, ma anche il modo con cui ci ascoltano le persone a cui ci rivolgiamo.
Mi dicevi, prima ancora che io leggessi il libro, che avevi scritto usando troppo la parola “io” e che nelle future scritture vorresti “distaccarti” un po’, lasciare uno spazio ancora maggiore ai tuoi amici yanomami e, se così posso dire, alle esperienze che fanno parte della tua esperienza ma che vanno anche oltre.
Ti trascrivo un frammento di un’intervista a Selimovic: “Io credo che nel romanzo tutto sia personale, indipendentemente dalla questione se esso sia una autobiografia oppure la biografia di un altro. Lo scrittore deve sperimentare tutto, se non come ha fatto, almeno come possibilità, come emozione. Del resto non parlo volentieri della mia vita, perché ritengo che l’opera letteraria sia una realtà autonoma, che deve vivere indipendentemente dal possibile impulso iniziale. …tutto è frutto dell’immaginazione, ma l’immaginazione deve creare su qualcosa che è stato sperimentato.”
Dice così, a un certo punto, la protagonista femminile della trilogia di Ben Jelloun, quando si sostituisce al narratore della sua storia e inizia a raccontare direttamente la sua storia agli ascoltatori lì riuniti, in quella piazza da dove in qualche modo lei e la sua storia erano partiti tanto tempo prima: “La piazza è sempre rotonda. Come la follia. Non è cambiato niente. Né il cielo, né gli uomini. Sono contenta di essere finalmente qui. Voi siete la mia liberazione, la luce dei miei occhi. Le mie rughe sono belle e tante. Quelle sulla fronte sono le tracce della verità e la testimoniano. Sono l’armonia del tempo. Quelle sul dorso della mano sono le linee della buona e della cattiva sorte. Guardate come s’intrecciano: indicano percorsi del destino e disegnano una stella dopo la sua caduta nelle acque di un lago. E’ qui che sta scritta la storia della mia vita: ogni ruga è un secolo, una strada in una notte d’inverno, una sorgente di acqua limpida nelle brume del mattino, un incontro in una foresta, una rottura, un cimitero, un sole incendiario… (…) Ho superato ogni sorta di violenze per meritarmi la passione e diventare un enigma. Ho camminato per tanto tempo nel deserto; ho misurato la notte e addomesticato il dolore. Ho conosciuto la “lucida ferocia dei giorni migliori”, quei giorni in cui tutto ti sembra tranquillo. Amici! Quanto sto per confidarvi sembra vero.”
Amin Malouf riscopre le origini sue e della sua tribù di beduini (inizia a riscoprirle) attraverso una ricerca che parte da una valigia di lettere lasciate un secolo prima dal nonno in un armadio in Libano (lasciate proprio perché qualcuno un giorno le ritrovasse) e lo porta a Cuba a girovagare per le strade dell’Avana, a fare domande, raccogliere le ultime testimonianze ancora non dissolte dal tempo, per rimetterle insieme. In realtà, tutto questo viaggio a ritroso nel tempo e nello spazio, si sviluppa interamente (mentre se ne sta a Parigi) dentro alla sua testa, alle sue idee e percezioni, è come uno svelamento continuo di emozioni, sentimenti, percezioni che già c’erano ma non sapevano di esserci.
È un viaggio che cambia chi lo fa e quando lo si racconta si finisce, forse, con l’oscillare sempre tra il racconto del viaggio (e del mondo attraversato) e il racconto del cambiamento (che ci attraversa dentro), non si può sapere dove termina uno e dove inizia l’altro di questi due aspetti, o dove s’incontrano. E forse avviene la stessa cosa anche quando lo si legge questo racconto, non si può capire bene da quali di questi due aspetti l’attenzione sia più attratta. Come se si volesse al tempo stesso immergersi in quel mondo raccontato, così come dovrebbe essere nella sua realtà interna, per (ri)viverlo, sentirlo addosso e immaginarne i mutamenti che ci produce addosso, e al tempo stesso, mentre si legge, guardare invece cosa sta facendo o vivendo il suo narratore, con il quale cerchiamo di misurarci, perché si sta facendo carico, per noi , del viaggio.
Quando mi avevi detto che avevi scritto usando troppo la parola “io” e che in seguito avresti voluto “distaccarti” un po’, non avendo ancora letto il tuo libro (o valutando in quel momento in modo superficiale) forse avevo frainteso, come se ti riferissi a una sorta di obiettivo letterario finale attraverso una marcia di avvicinamento, di esercizio di miglioramento, di progressiva e sempre più matura assimilazione o rielaborazione di un mondo di esperienze da raccontare con un tono più distaccato.
Avevo capito male. A me è sembrato che questo tuo parlare in prima persona usando la parola “io”, come narratore, sia stato come assumere coraggiosamente e con chiarezza l’angolo visuale da cui lanciare lo sguardo, se si vuole vedere quello che hai visto e vedi.
“Io” non sostituirei la parola “io”. Continuerei a farla muovere, camminare, raccontare, ricercare, così come ha già iniziato a fare. Semmai, c’è la consapevolezza di muoversi in mezzo ad altri “io” e altri punti di vista, altri mondi di percezioni il cui significato non è esauribile, e con cui ci rapportiamo e vogliamo continuare a rapportarci.
Forse, distaccarsi e parlare “anche” in terza persona, significa quasi fare una “manutenzione” del mondo con cui vogliamo continuare a rapportarci, sia nel senso di mantenerlo vivo, con le sue cose e il suo modo di esprimersi da solo su se stesso, per farsi conoscere, sia nel senso di continuare noi a svelarlo, perché poi è proprio in questo rapporto che si può continuare a svelare se stessi.
Quindi, forse, non si tratta dell’uso della prima o della terza persona e tantomeno dell’equilibrio nel loro uso; forse, si tratta di farli convivere insieme, contemporaneamente, proprio nel loro “squilibrio” e inconciliabilità, due punti di vista o modi di sentire che formano nello stesso momento la propria identità, la quale è fatta da entrambi.
Il viaggio nel mondo o il viaggio nell’io?
* Tullio Bugari è il Coordinatore dell’Associazione culturale Altroviaggio di Jesi (AN).
–
–