Nil sapientiae odiosius acumine nimio.
(niente è più odioso dell’intelligenza con troppa furbizia)
Seneca.
Nel 18… ero a Parigi. Dopo una triste e tempestosa serata autunnale, potevo godere la
doppia voluttà d’un meditativo raccoglimento e d’una pipa di schiuma, in compagnia del mio amico
C. Auguste Dupin, nella sua piccola biblioteca – che fungeva anche da studio – al terzo piano del
numero 33 della via Dunôt al Faubourg Saint-Germain. Durante un’ora intera restammo in silenzio,
per modo che ciascuno di noi-, al primo venuto, sarebbe apparso profondamente ed esclusivamente
compreso delle arricciolate anella di fumo che volteggiavano per la stanza. Per quel che riguardava
me, ero immerso a discutere meco stesso attorno a certi punti ch’erano stati oggetto, nella prima
parte della serata, della nostra conversazione: voglio dire dell’affare della via Morgue e del mistero
relativo all’assassinio di Marie Rogêt. Cercavo di connetter tra loro le coincidenze che potevano
riscontrarsi in quei due casi, allorché la porta del nostro appartamento fu aperta e apparve, nel vano,
la vecchia conoscenza di Monsieur G., prefetto della polizia parigina.
Gli demmo cordialmente il benvenuto, dal momento che, ai suoi lati negativi, facevano pure
contrasto alcune positive qualità e, del resto, non lo vedevamo da più di qualche anno. Poiché
eravamo seduti al buio, Dupin si levò nell’intento di accendere una lampada: e nondimeno tornò a
sedere senza aver compiuta quell’operazione, avendo inteso da Monsieur G. ch’egli era venuto a
consultarci, o meglio a chiedere l’opinione del mio amico, circa un affare che gli aveva causato
increscioso imbarazzo.
«Ove si tratti d’un caso che richieda della riflessione», osservò Dupin, astenendosi in quel
punto dall’accendere la calza, «sarà per noi più conveniente procedere nel nostro esame al buio».
«Ecco ancora una delle vostre bizzarre trovate», disse il prefetto, il quale aveva la mania di
chiamare bizzarre tutte le cose al di fuori delle sue capacità di comprendere, e che si trovava in tal
modo a vivere in mezzo a una immensa legione di bizzarrie.
«È proprio così», disse Dupin porgendo una pipa al nostro visitatore e spingendo verso di lui
una comoda poltrona.
«Qual è dunque questo caso imbarazzante?», chiesi io, a questo punto. «Spero bene che non
si tratti, anche questa volta, d’un assassinio».
«Oh, no! Nulla di simile. È un fatto che questo nuovo affare si presenta d’una estrema
semplicità. Ed io non metto in dubbio che sapremmo cavarcela da noi, stessi. Se sono accorso a
raccontarlo a Dupin è solo perché egli non potrà far di meno che interessarsi, appunto, alla sua
bizzarria».
«Semplice e bizzarro insieme», disse Dupin.
«Infatti: e nondimeno tale espressione non è del tutto esatta. L’uno o l’altro, se credete
meglio. È un fatto che no, siamo tuttora vittime d’un totale smarrimento, per quel che riguarda tale
affare, dal momento che, per quanto sia semplice, non riusciamo ad afferrarne il bandolo».
«È probabile che sia la sua stessa semplicità a indurvi nell’errore», disse il mio amico.
«Quale sciocchezza non vi siete lasciata sfuggire!», replicò il prefetto, ridendo di cuore.
«Forse il vostro mistero non è che troppo chiaro», disse Dupin.
«O cielo! Chi ha mai sentito, prima d’ora, profferire una simile stravaganza?».
«Troppo chiaro, dunque».
«Ah! Ah!… Oh! Oh! …», strillò il nostro ospite coll’aria di divertirsi un mondo. «Oh, caro il
mio Dupin, mi volete far morire dal ridere, voi!».
«Alle corte», dissi io. «Di che si tratta?».
«Me ne sbrigherò», disse il prefetto esalando una lunga, solida e contemplativa boccata di
fumo, e accomodandosi a sedere sulla sua poltrona, «me ne sbrigherò in poche parole. Ma prima di
cominciare, permettete che v, faccia presente come l’affare richieda il più scrupoloso segreto e come
io perderci, con tutta probabilità, il mio impiego ove si venisse a sapere che l’ho sussurrato a
chicchessia».
«Cominciate», dissi io.
«Oppure non cominciate», disse Dupin.
«Va bene. Comincio. Sono stato informato personalmente, ed in altissimo loco, che un certo
documento, cui è annessa la massima importanza, è stato sottratto dagli appartamenti reali.
L’individuo che ha compiuto il furto ci è noto. Non sussiste, attorno alla sua identità, alcun dubbio:
è stato visto nell’istante medesimo in cui si è appropriato del documento. Ed è noto, altresì, che quel
documento è tuttora in suo possesso».
«E come si fa a saperlo?», chiese Dupin.
«Si deduce dalla natura del documento stesso e dal non darsi di alcuni fatti che sarebbero
immediatamente provocati qualora esso cessasse d’essere, appunto, in possesso del ladro. In altri
termini: se esso fosse impiegato in vista dello scopo che il ladro, evidentemente, si propone».
«Spiegatevi meglio», dissi io.
«Ebbene, arriverò a dire che tale documento conferisce, a chi lo detiene, un potere in un
certo luogo nel quale il sullodato potere ha un valore inestimabile». E così dicendo il prefetto
traboccava del gusto di ostentare il suo pudore ipocrita da diplomatico.
«Eppure io continuo a non capire nulla», disse Dupin.
«Nulla sul serio?… Via! Quel documento, dunque, ove fosse esibito a un terzo personaggio,
del quale tacerò il nome, metterebbe in imbarazzo l’onore d’una persona d’altissimo grado… ed
eccovi ciò che conferisce, a chi detiene il documento, un ascendente su quella tale illustre persona,
della quale l’onore e la sicurezza sono, in tal modo, messi a rischio …».
«Ma questo ascendente», interruppi io, «dipende soltanto dal fatto che il ladro sappia, o
meno, se il derubato è a parte della sua identità… e chi oserebbe?».
«Il ladro», disse Monsieur G., «non è altri che D., il quale osa tutto ciò che è indegno di un
uomo, così come non si fa scrupolo d’usare anche ciò che ne è degno. Il metodo con cui è stata
condotta la ruberia fu ingegnoso del pari che ardito. Il documento in questione – una lettera, per
essere più espliciti – era stato ricevuto da colui che ne fu derubato, mentre questi era solo
nell’appartamento reale, ma mentre costui lo stava leggendo, fu interrotto dall’improvviso entrare
dell’altro illustre personaggio al quale egli aveva ragioni tutte particolari per nasconderlo. Dopo
aver tentato, invano, di gettarlo rapidamente in un cassetto, egli fu obbligato a deporlo, aperto
com’era, sul tavolo. La lettera, nondimeno, era rovesciata, coll’indirizzo fuori, e, il suo contenuto
rimanendo così nascosto, essa non fu notata. Sopraggiunge, nel frattempo, il ministro D. La carta
sul tavolo non sfugge al suo occhio di lince, la calligrafia dell’indirizzo viene riconosciuta, notato
l’imbarazzo del destinatario e penetrato, in breve, il suo segreto.
«Dopo aver trattati alcuni affari – in modo spiccio, secondo le sue abitudini – il ministro D.
trae di tasca una lettera pressoché identica a quella in questione, fa l’atto di leggerla, e la depone
proprio a fianco dell’altra. Quindi riprende a parlare, per un quarto d’ora all’incirca, dei pubblici
affari. Prende infine congedo e pone in mano, nell’andarsene, la lettera della quale egli non ha
diritto alcuno di porla. La persona derubata se ne accorge ma, naturalmente, non osa attirare, su
quella circostanza, l’attenzione del terzo personaggio che gli era a lato. E così il ministro esce dalla
stanza lasciando sul tavolo la propria lettera, una lettera – c’è bisogno ch’io lo aggiunga? –
senz’alcuna importanza».
«Così», disse Dupin volgendosi a metà dalla mia parte, «si dà perfettamente il caso richiesto
perché l’ascendente sia completo: il ladro sa che la persona derubata conosce, appunto, il ladro».
«Già», rispose il prefetto, «senza contare che, per qualche mese, secondo un certo
intendimento politico, è stato fatto il debito uso del potere acquisito con un tale stratagemma, e fino
a un limite, occorre aggiungere, altamente pericoloso. Il derubato è convinto, ogni giorno di più,
dell’assoluta necessità d’avere indietro la sua lettera. E nondimeno ciò non può compiersi
apertamente. Spinto, infine, dalla disperazione, egli ha commesso a me il delicato incarico di
recuperarla».
«Era infatti impossibile, per quel che so», disse Dupin circonfuso d’una aureola di fumo,
«scegliere o, meno ancora, inventare un agente più sagace».
«Voi mi lusingate», replicò il prefetto, «e tuttavia non è impossibile che alcuno abbia
concepita, di me, una simile opinione».
«È chiaro», intervenni a dire io, «come, del resto, voi stesso non avete mancato di notare,
che la lettera è tuttora nelle mani del ministro; dal momento che soltanto il suo possesso – e non
l’uso – è ragione dell’ascendente. Con l’uso, infatti, l’ascendente scompare».
«È così», disse Monsieur G., «ed io ho iniziate le mie indagini, forte, appunto, di tali
convincimenti. Mia prima cura e stata, infatti, di operare una minuziosa perquisizione nella casa del
ministro: di tale perquisizione il principale imbarazzo consistette nel procurare che gli rimanesse
sconosciuta. lo badai, soprattutto, a non dargli motivo di sospettare i nostri disegni».
«Penso che dovreste trovarvi a vostro agio completo», dissi io, «in simile genere di
investigazioni. La polizia parigina non è davvero nuova a operazioni consimili».
«Oh, non c’è dubbio! Ed è appunto per questo ch’io nutrivo speranza di raggiungere il mio
scopo. Le abitudini del ministro, del resto, mi riuscirono di non poco vantaggio. Egli usa di
frequente restare assente da casa sua tutta la notte. I suoi domestici non sono numerosi. Essi
dormono a una certa distanza dall’appartamento del loro padrone e poiché sono, dal primo
all’ultimo, napoletani, si prestano facilmente a essere ubriacati. lo posseggo – come voi, del resto,
sapete – una sorta di grimaldelli coi quali posso aprire le porte di tutte le camere e di tutti i gabinetti
di Parigi.
Così che, durante tre lunghi mesi, non è trascorsa una sola nottata ch’io non abbia
impiegata, nella maggior parte, a frugar di persona nell’abitazione del ministro D… Il mio onore vi è
interessato e – per confidarvi un gran segreto – la ricompensa che mi è stata promessa è enorme. Per
modo che non ho abbandonato le mie ricerche altro che al momento in cui cominciò a farsi strada,
in me, la convinzione che il mio ladro fosse assai più furbo di me. Credo, infatti, d’avere esaminati
tutti gli angoli e i possibili nascondigli nei quali era possibile celare il segreto di quella lettera».
«E non sarebb’egli possibile», insinuai lo a questo punto, «che la lettera, benché in possesso
del ministro (non v’ha dubbio in proposito) sia stata, dallo stesso ministro, nascosta in luogo diverso
dalla propria abitazione?».
«No, ciò non è possibile», intervenne a dire il mio amico Dupin. «La situazione particolare
dell’attuale momento, a Corte, ed in special modo la natura dell’intrigo nel quale s’è cacciato il
ministro D. rendono l’efficacia immediata del documento – il poterlo produrre a tamburo battente –
un fattore pressoché importante quanto il suo possesso».
«Il poterlo produrre?», chiesi io.
«O, se più vi aggrada, il poterlo distruggere», disse Dupin.
«È vero», convenni io; «la lettera è senz’altro nell’abitazione del ministro. Quanto alla
possibilità che essa si trovi addosso alla stessa persona del ministro, io ritengo che debba
considerarsi del tutto fuor di questione».
«Del tutto», disse il prefetto; «io l’ho fatto fermare ben due volte da alcuni agenti camuffati
da borsaiuoli e la sua persona è stata scrupolosamente frugata da capo a piedi sotto i miei stessi
occhi».
«Avreste potuto risparmiarvene la pena», disse Dupin; «il ministro D. non è per nulla così
pazzo, secondo almeno quel ch’io ne so, da non prevedere tali imboscate come incidenti tutt’affatto
naturali».
«Egli non è per nulla un pazzo, è vero», disse Monsieur G.; «ciò nondimeno egli è un poeta,
il che, secondo il mio parere, non è molto diverso dall’esser pazzo».
«D’accordo», disse Dupin dopo avere a lungo e pensosamente soffiato fuori qualche boccata
di fumo dalla sua pipa di schiuma, «benché io stesso mi sia reso colpevole d’un qualche libero
verso».
«Al dunque», dissi io, «raccontateci gli esatti particolari delle vostre ricerche».
«Gli è che noi abbiamo cominciato per tempo, così che abbiamo avuto agio di cercare
dappertutto. Io posseggo una antica esperienza in siffatto genere di indagini. Abbiamo esaminata la
casa per intero, una camera dopo l’altra: e abbiamo consacrato a ciascuna le notti di tutta una
settimana. Siamo passati, quindi, a esaminare i mobili di ciascun appartamento, abbiamo aperti tutti
i possibili cassetti ed io presumo che voi non ignoriate come, per un agente di polizia quale si deve,
un cassetto segreto sia una espressione senza significato. Colui che, in una perquisizione di tal
natura, si lasciasse sfuggire un cassetto segreto, è un idiota. E del resto la cosa è facilissima. In ogni
vano si trova una certa quantità di volume e di superficie della quale è possibile fare un conto
esatto. Noi possediamo regole tutte particolari ed infallibili per questa bisogna. Non potrebbe
sfuggirci la quindicesima parte della sezione di un filo. Dopo aver esaminate le stanze, passammo
alle sedie. I cuscini furono sondati con dei lunghi aghi affilati dei quali voi già conoscete l’impiego.
I tavoli furono scoperchiati …».
«E perché?».
«Talvolta s’usa togliere i ripiani dei tavoli o di qualsivoglia altro mobile, e se ne forano i
piedi, o comunque i sostegni alla sommità, onde nascondervi l’oggetto che si intende far scomparire.
Compiuta l’operazione, i ripiani vengono posti nuovamente al loro luogo primitivo. Ci si serve allo
stesso modo dei montanti del letto …».
«E non si potrebbe indovinare la presenza della cavità semplicemente tentando le pareti?»,
obiettai io.
«Nient’affatto, ove si abbia la precauzione, nel depositare l’oggetto incriminato, d’avvolgerlo
d’una benda di cotone atta a riempire l’interstizio. Del resto, nel nostro caso, eravamo obbligati a
procedere senza fare il minimo rumore».
«Ma voi non avete potuto smontare, non avete potuto disfare tutti i mobili nei quali era
possibile nascondere la lettera nel modo che avete indicato. Giacché essa poteva anche essere
avvolta in una spirale sottile quanto un ferro da calza, ed essere inserita, così, nel piede d’una
seggiola. Avete smontato tutte le seggiole?».
«Nient’affatto. Ma abbiamo fatto di meglio. Abbiamo esaminato le gambe di tutte quelle che
si trovavano nella casa, come pure le giunture d’ogni mobile, con l’aiuto d’un potente microscopio.
Se ci fosse stata la minima traccia d’una recente manomissione, questa non sarebbe per certo
sfuggita alla nostra indagine. Un solo granello di polvere che potesse essere smosso da un
succhiello ci sarebbe apparso grande come una mela. La minima alterazione nella collatura, la più
lieve sconnessione tra le giunture ci avrebbe rivelato il nascondiglio».
«Presumo che abbiate esaminato gli specchi nel loro interno e che abbiate frugato i letti e i
loro cortinaggi, così come le tende alle finestre e i tappeti».
«Naturalmente. E una volta passati in rivista a questo modo gli oggetti dello stretto
ammobiliamento, abbiamo esaminata la casa vera e propria. Ne abbiamo divisa la totalità del
volume e della superficie in altrettanti compartimenti che poi abbiamo contraddistinto, da un
numero affinché potessimo andar sicuri di non ometterne alcuno. Abbiamo fatto, di ciascuna
sezione che ne risultava, l’oggetto d’un nuovo esame microscopico e vi abbiamo anche compreso i
due appartamenti adiacenti».
«Due appartamenti adiacenti?», esclamai. «Vi siete dovuti addossare, così, non poco
fastidio».
«Non poco, per la verità. Ma la posta, come ho detto, era enorme».
«Vanno compresi anche gl’impiantiti, negli appartamenti?».
«Essi sono tutti a mattonelle. Posso dire che, relativamente al resto, l’esame degli impiantiti
è stato una cosa da nulla. Fu sufficiente esaminare l’impasto di polvere tra una mattonella e l’altra:
esso era vergine dappertutto».
«E avrete senza dubbio dato un’occhiata anche alle carte del signor ministro… ai libri della
sua biblioteca …».
«Certamente. Abbiamo aperto ogni cartella, scartabellato ogni memoriale. Non abbiamo
soltanto aperto i libri ma li abbiamo sfogliati pagina per pagina, senza contentarci d’una scorsa
sommaria come purtroppo è nell’uso, ormai invalso, dei nostri ufficiali di polizia. E così abbiamo
anche esaminato lo spessore di ciascheduna legatura colla più esatta meticolosità, e ad ognuna
abbiamo applicata la gelosa curiosità del microscopio. Ove qualche oggetto fosse stato inserito di
recente in una legatura, quell’oggetto non sarebbe potuto sfuggire alla nostra osservazione. Cinque o
sei volumi che uscirono, durante quei giorni, dalle stesse mani del legatore, furono passati da parte a
parte e accuratamente sondati in senso longitudinale da appositi aghi».
«Avete esplorati gli assiti, sotto i tappeti?».
«Naturalmente. Abbiamo tolti i tappeti uno per uno e abbiamo esaminato i regoli al
microscopio».
«E la carta ai muri?».
«Anche quella».
«E le cantine?».
«Abbiamo fatta una visita anche alle cantine».
«Per modo che vi siete accorti d’avere sbagliato strada», dissi io, «e che la lettera non era
nella casa del ministro, come avevate supposto in un primo luogo».
«Suppongo che non v’inganniate, su questo punto», rispose il prefetto, e poi, rivolto al mio
amico: «Ed ora, signor Dupin, che mi consigliate di fare?».
«Tornate a perquisire completamente la casa».
«È assolutamente inutile», strillò Monsieur G. «Sono sicuro che la lettera non è
nell’appartamento, come sono sicuro, in questo momento, di parlare a voi».
«E nondimeno non ho alcun consiglio migliore che questo da darvi», disse Dupin.
«Immagino, comunque, che vi abbiano descritta minutamente codesta lettera».
«Sì, sì», e il prefetto trasse di tasca un suo quadernuccio e si mise a leggerci ad alta voce una
minuta descrizione dell’oggetto delle sue ricerche, del suo aspetto interno e di quello esterno. Finita
che ebbe la lettura di quel suo promemoria, quell’eccellente individuo prese congedo da noi così
depresso di spirito, ch’io non mi ricordavo d’averlo mai visto in quello stato prima d’allora.
A un mese all’incirca da quella conversazione, il degno uomo ci fece una seconda visita e ci
trovò occupati, press’a poco, nei medesimi esercizi dell’altra volta. Prese così anch’egli una pipa e
una poltrona e cominciò a chiacchierare seco noi del più e del meno.
«E allora? caro Monsieur G. E la vostra lettera rubata? Suppongo che vi siate rassegnato,
infine, ad ammettere che non è davvero una bagatella sbaragliare un ministro».
«Che il diavolo se lo porti! Non ch’io non abbia seguito il consiglio di Dupin e perquisito di
nuovo l’appartamento, veh! Pure, come prevedevo, fu fatica sprecata».
«A quanto ammonta la ricompensa che v’hanno offerta? Ci avete detto, mi pare …», chiese
Dupin.
«Mah… essa e molto forte… una ricompensa davvero munificentissima… Non sono
autorizzato a far cifre… ma questo posso dirvi, e che cioè m’impegnerei a sborsare di mio qualcosa
come un cinquantamila franchi a colui che potesse scovarmi la lettera. È un fatto che la cosa diviene
di giorno in giorno più urgente. E la ricompensa è stata addirittura raddoppiata negli ultimi giorni. E
potrebbero anche triplicarla. Del resto, per quel che riguarda me… non potrei davvero aver
compiuto meglio il mio dovere di quanto, in effetti, non l’abbia compiuto».
«Ma… sì …», disse Dupin strascicando le parole frammezzo alle fumate della sua pipa. «Io
credo, a esser sincero… caro Monsieur G., che voi non abbiate fatto tutto il vostro dovere… è
impossibile non riconoscere che voi non siete arrivato fino in fondo alla questione… voi potreste
fare… un po’ di più. Questa è almeno la mia franca opinione. Che ne dite?».
«Come? In che senso?».
«Ma …» e una fumata, «voi potreste …» e due fumate, una sull’altra, «voi potreste mettere un
po’ più d’impegno nell’affare …» e tre fumate. «Vi rammentate la famosa storia d’Abernethy?».
«Al diavolo il vostro Abernethy!».
«E sia pure, al diavolo! Se ciò vi diverte. Or dunque, una volta, un certo signore, avaro
quanto ricco, concepì il disegno di scroccare ad Abernethy un consulto medico. E a questo scopo
intavolò secolui, durante un ricevimento, una conversazione ordinaria attraverso la quale sottopose
al medico il suo proprio caso, come se si trattasse di quello d’un personaggio immaginario.
“Supponiamo”, disse l’avaro, “che i sintomi sian questi e questi. Ed ora, caro dottore, cosa
consigliereste al poverino?” “Cosa consiglierei?”, rispose Abernethy, “gli consiglierei d’andare a
consigliarsi con un medico. È l’unica cosa da fare”».
«Ma io», disse a questo punto il prefetto, un po’ sconcertato, a dire il vero, «non solo sono
dispostissimo a prendere consiglio, ma anche a pagarlo. Io darei sul serio i cinquantamila franchi a
chiunque mi togliesse d’impiccio».
«In questo caso», disse Dupin aprendo un cassetto della sua scrivania e traendone fuori un
libretto di assegni, «voi potete fare una firma per la somma suddetta. Quando l’avrete ben bene
vergata, vi rimetterò la vostra lettera».
Io ero al colmo della meraviglia. Quanto al prefetto, sembrava addirittura fulminato. Rimase
alcuni istanti immobile e muto guardando il mio amico, con la bocca spalancata e con un residuo
d’incredulità negli occhi che sembravano sul punto di schizzargli fuori del capo. Parve, infine,
rientrare man mano in sé, prese e intinse una penna, e non senza qualche esitazione, con lo sguardo
vuoto, proteso a scrutare misteriose distanze, riempì e firmò un assegno da cinquantamila franchi, e
lo porse a Dupin, al di sopra del tavolo. Questi lo esaminò minuziosamente e lo ripose quindi nel
suo portafoglio. Indi sollevò una tavoletta dello scrittoio, ne trasse una lettera e la porse al prefetto.
Quel degno funzionario l’agguantò con una sorta di spasimo di felicità, l’aprì colle mani tremanti,
buttò un’occhiata al suo contenuto e poi, precipitandosi verso la porta, scomparve, senza altra
cerimonia, dalla stanza, senza che avessimo potuto cogliere dal suo labbro una sola sillaba dal
momento in cui Dupin l’aveva pregato di firmare l’assegno.
Quand’egli fu fuori, il mio amico consentì a qualche spiegazione.
«La polizia parigina», egli disse, «è estremamente abile e avveduta per ciò che concerne il
suo mestiere. I suoi agenti sono perseveranti, ingegnosi, furbi, e posseggono a fondo tutto il
bagaglio di nozioni richiesto dal loro specialissimo mandato. Per modo che quando Monsieur G. ci
forniva il particolareggiato ragguaglio della sua perquisizione in casa del ministro D., io serbavo
una stima totale per il talento di cui dava mostra ed ero perfettamente convinto che egli aveva
compiuta una investigazione affatto soddisfacente nei limiti delle sue specialità».
«Nei limiti delle sue specialità?», chiesi io.
«Appunto», disse Dupin. «Le misure adottate non furono soltanto le migliori: esse furono
spinte, altresì, ad una perfezione assoluta. Se la lettera fosse stata nascosta nel raggio della loro
investigazione, essi l’avrebbero certamente trovata. Su ciò, io non ho il minimo dubbio».
A questo punto, mi contentai di sorridere, ma Dupin aveva l’aria d’aver detta la surriferita
proposizione in tutta serietà.
«Le misure, dunque», egli continuò, «erano buone e ammirevolmente poste in funzione.
Esse avevano soltanto il difetto di essere inapplicabili, non solo alla fattispecie del caso, ma
soprattutto, all’uomo. V’ha un dispiegamento di mezzi singolarmente ingegnosi che costituiscono,
per il signor prefetto, una sorta di letto di Procuste, e sui quali egli adatta e misura tutti i suoi piani.
Ed egli, nondimeno, nel caso particolare del ministro D., è rimasto addietro per un eccesso di
perspicacia e insieme di superficialità. Più di uno scolaretto avrebbe ragionato meglio di lui. Ho
conosciuto un bimbo di otto anni, nel quale la infallibilità al giuoco di pari e dispari era oggetto
d’ammirazione universale. Il giuoco è estremamente semplice: uno dei giocatori tiene in mano un
certo numero di palline e domanda all’altro: “Pari o dispari?”. Se l’altro indovina giusto, avrà
guadagnato una pallina, s’egli si sarà, invece, ingannato, ne avrà persa ugualmente una. Il bimbo di
cui ho detto, vinceva invariabilmente tutte le palline della scuola. Naturalmente egli possedeva una
sorta di capacità divinatoria, la quale consisteva nella semplice osservazione e nell’apprezzamento
della finezza di penetrazione dei suoi avversari. Supponiamo che il suo avversario sia un grullo
completo, e, levando alta la manina chiusa, dica: “Pari o dispari?”. Il nostro scolaro risponde,
mettiamo: “Dispari”, e, mettiamo ancora, perde. Ma alla seconda prova egli vincerà perché farà, a se
stesso, il seguente ragionamento: lo scioccherello aveva un numero di palline pari, la prima volta;
tutta la furberia potrà spingerlo, al massimo, a metterne, la seconda, un numero dispari, e quindi
tanto vale dire: “Dispari” ancora una volta. Egli dice “Dispari” e vince. Ma con un avversario meno
semplice, egli ragione così: questo qui s’è accorto che lo, la prima volta, ho detto “Dispari” e alla
seconda partita diviserà, in un primo momento, di mutare i pari in dispari come ha fatto l’altro, ma
in un secondo momento penserà che un cambiamento di quel tipo pecca di eccessiva semplicità, e si
deciderà a mettere pari una seconda volta. lo dirò “Pari”, quindi. E il bimbo dice “Pari” e vince. Ora
il modo di ragionare del nostro bimbo, che i suoi compagni peraltro chiamano fortuna, che cos’è, in
ultima analisi?».
«Esso non è che un processo d’identificazione del nostro intelletto con quello del nostro
avversario», risposi io.
«Appunto», disse Dupin. «E come io domandai a quel bimbo con qual mezzo egli
effettuasse quella perfetta identificazione che faceva tutto il suo successo, ne ebbi la risposta
seguente: “Quando lo voglio sapere fino a che punto uno sia accorto o sciocco, fino a che punto sia
buono o cattivo, o quali siano, in quel punto, i suoi pensieri, cerco d’atteggiare il viso così come lo
vedo atteggiarsi in lui, e aspetto di saper quali pensieri e quali sentimenti nascono, in me,
compatibili, appunto, con quella fittizia fisionomia che ho assunta”. Questa risposta dello scolaro
confonde non poco, mi sembra, tutta la sofistica saggezza attribuita a La Rochefoucauld, a La
Bruyère, a Machiavelli e a Campanella».
«Per modo che l’identificazione dell’intelletto del ragionatore con quello del suo avversario
dipende, se ho ben compreso, dall’esattezza con cui viene valutato l’intelletto, appunto, di
quest’ultimo».
«Per ciò che riguarda il valore pratico del procedimento, quella valutazione ne è, in effetti, la
condizione principale», replicò Dupin, «e se il prefetto e tutta la sua banda si sono ripetutamente
ingannati, l’errore va cercato in quella identificazione che hanno omessa di tentare, e, in secondo
luogo, nella valutazione inesatta, o meglio nella non-valutazione della intelligenza con la quale
stavano misurandosi. Essi non vedono al di là dei propri ingegnosi ritrovati. E ove si mettano alla
ricerca d’un oggetto nascosto, non pensano che ai mezzi che avrebbero usati essi stessi per
nasconderlo. Essi hanno tuttavia ragione di ritenere che la loro propria perspicacia è una fedele
rappresentazione di quella del volgo. Così, quando sono alle prese con un mariuolo la cui
sottigliezza differisce dalla loro, quel mariuolo, naturalmente, riesce a gabbarli. Ciò non manca mai
di accadere tutte le volte che l’astuzia di costui è al di sopra della loro, e ciò accade assai spesso
anche quando essa è, per contro, al di sotto. Essi non modificano affatto i loro sistemi di
investigazione: tutt’al più, quando sono spronati da un qualche caso insolito, ovvero, più
esattamente, da una insolita ricompensa, essi esagerano e portano all’esasperazione i loro vecchi
espedienti. E nondimeno lasciano immutati i loro principi. Nel caso, ad esempio, del ministro D.,
che cosa è stato fatto per cambiare il metodo dell’investigazione? A che valgono tutte quelle
perforazioni, quei frugamenti, quei sondaggi, quegli esami al microscopio, quella divisione della
superficie in sezioni numerate? Che cosa è tutto questo armamentario se non l’esagerazione,
nell’applicarli, d’uno o di più principi d’investigazione, basati su un ordine di idee relativo
all’ingegno umano ed ai quali il prefetto si è abituato nell’ormai annoso esercizio delle sue funzioni?
Non vi accorgete che egli considera un fatto ampiamente dimostrato che tutti gli uomini i quali
vogliono nascondere una lettera si servano, se non d’un buco fatto col succhiello nella gamba d’una
seggiola, d’un qualsivoglia altro buco o sotterfugio, almeno, tutt’affatto singolare e sempre
nell’ordine d’invenzione, però, del solito buco trapanato? E non vi rendete conto, ancora, che
nascondigli d’una siffatta originalità, non sono impiegati che in occasioni ordinarie e adottati da
intelligenze ordinarie? Giacché in qualsivoglia caso d’oggetto nascosto, tale maniera maliziosa e
involuta insieme di nasconderlo, e, nel suo stesso principio, del tutto presumibile e, di fatto,
presunta? Per modo che la sua scoperta non dipende, in nulla, dalla perspicacia, ma soltanto dalla
cura, dalla pazienza, dalla buona volontà, insomma, di coloro che sono incaricati della ricerca. Ma
quando il caso riveste un’importanza particolare, ovvero – il che è la medesima cosa, agli occhi della
polizia – quando la ricompensa è particolarmente importante, ci s’avvede che tutte queste belle
qualità falliscono invariabilmente il loro scopo. Spero che ora abbiate compreso ciò che io
intendevo affermando che, ove la lettera rubata fosse stata nascosta nel raggio in cui il signor
prefetto organizzò così brillantemente la sua perquisizione, – in altri termini, se il principio
ispiratore del nascondiglio fosse stato compreso nella somma dei principi del prefetto – egli
l’avrebbe scoperta senza fallo. Ciò nondimeno il nostro funzionario è stato completamente giocato,
e la causa principale di questa presa in giro risiede tutta nella supposizione, del prefetto, che il
ministro fosse un pazzo dacché s’era fatto una reputazione di poeta. Tutti i pazzi sono poeti,
secondo il punto di vista del prefetto, così che egli non è responsabile che d’una non distributio
medii deducendo da quella, l’altra proposizione che tutti i poeti sono pazzi».
«Ma si tratta poi veramente del poeta?», chiesi lo. «So che sono due fratelli e che entrambi si
son fatti una reputazione nel mondo letterario. Ma il ministro, a quel che mi pare di ricordare, deve
avere scritto un importante volume sul calcolo differenziale e integrale. Egli dovrebb’essere il
matematico, non il poeta».
«Siete in errore: io lo conosco assai bene: egli è poeta e insieme matematico. E come poeta e
matematico, ha dovuto ragionare a dovere. Se fosse stato soltanto matematico, non avrebbe fatto
che una parte soltanto del ragionamento necessario, e si sarebbe, in tal modo, esposto alla mercé del
nostro prefetto».
«Una siffatta opinione», esclamai, «non può non meravigliarmi. Essa è smentita,
coralmente, dal buon senso comune. Non avrete l’intenzione, spero, di sottovalutare una idea
maturata attraverso i secoli dei secoli. La ragione matematica non è soltanto da ora ritenuta come la
ragione per eccellenza».
«Il y a à parier», disse Dupin, citando Chamfort, «que toute idée publique, toute convention
reçue, est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. I matematici, ve lo accordo, han
fatto del loro meglio per propagare il popolare abbaglio di cui avete detto poc’anzi, il quale, benché
spacciato per una verità, è, nondimeno, un classico e perfezionato tipo di errore. Per esempio, con
carte e sottigliezza degne al certo d’una miglior causa, ci è stato appreso ad applicare il termine
analisi alle operazioni algebriche. I francesi sono i primi responsabili d’un siffatto imbroglio
scientifico. Ma, ove si convenga che i termini del linguaggio non hanno una loro reale
significazione, – se le parole, insomma, traggono la loro ragione e il loro valore solo dal modo
convenuto con cui vengono applicate, – concedo che la parola analisi traduca la parola algebra,
press’a poco come in latino ambitus traduce “ambizione”, religio, “religione”, e homines honesti, sta
per la categoria delle persone per bene».
«Mi accorgo», dissi io, «che state impancandovi in una disputa con un buon numero di
professori d’algebra di Parigi. Ma non importa: continuate».
«Io contesto la validità e, per conseguenza, i risultati d’un qualsiasi procedimento razionale il
quale s’avvalga d’altro principio che la logica astratta. E contesto, in maniera del tutto particolare, i
ragionamenti che tengono del procedimento proprio alle dottrine matematiche. Le matematiche
sono le scienze attinenti alle forme e alle quantità; il ragionamento matematico altro non è se non la
semplice logica applicata alla forma e alla sua quantità. Il grave errore consiste nel ritenere che le
verità ritenute puramente algebriche siano delle verità astratte e generali. E questo errore è talmente
madornale e gravido di conseguenze, ch’io non posso far di meno che meravigliarmi
dell’universalità colla quale, nonostante tutto, esso è accolto. Gli assiomi matematici non
pretendono affatto ad assiomi generali. Ciò che è vero per un rapporto di forma o di quantità, è
sovente un grossolano errore per ciò che riguarda, mettiamo, il mondo morale. In quest’ultima
scienza è troppo comunemente falso che la somma delle frazioni sia eguale all’intero. E così anche
nella scienza chimica troviamo che quell’assioma ha torto. Nell’apprezzamento che noi facciamo
d’una forza motrice, ad esempio, lo troviamo anche lì, fallace, dal momento che due motori che
siano ciascuno d’una data potenza, non posseggono affatto, una volta messa assieme la loro capacità
di traino, una potenza eguale alla somma delle loro potenze prese separatamente. E v’ha ancora
un’enorme quantità di verità matematiche le quali non sono delle verità che nei limiti del rapporto.
E nondimeno il matematico argomenta incorreggibilmente, basandosi su queste verità fisse, come se
esse potessero applicarsi in generale e in assoluto; il quale potere, del resto, è falsamente imprestato
loro anche dalla gente comune. Bryant, nella sua famosa Mythology, fa menzione d’una analoga
sorgente di errori allorché egli rileva che, quantunque nessuno creda alle favole mitiche dei pagani,
nondimeno noi usiamo trarne spesso delle conclusioni né più né meno che se esse riguardassero
fatti realmente accaduti. E hanno credito, d’altro canto, tra i nostri professori d’algebra, i quali sono
ancor essi dei pagani, talune favole pagane dalle quali sono state tratte persino lambiccate
congetture, non tanto per difetto di memoria, quanto per un incomprensibile ottenebrarsi delle
facoltà mentali. Io non ho mai incontrato dei matematici, per farla breve, nei quali potessi fidare
eccetto che per le loro radici quadrate e le loro equazioni; non ne ho mai conosciuto uno solo che
non tenesse in cuor suo per articolo di fede che x2 + px è assolutamente e incondizionatamente
eguale a q. Provate a dire a uno di cotesti signori, tanto per fare una prova, che voi credere alla
possibilità che x2 + px, non sia affatto eguale a q e quando sarete riuscito a fargli capire che cosa
intendere dire, procurate immantinente di mettervi al largo della sua portata, giacché egli, senza
dubbio, sarà intenzionato d’accopparvi!
«Voglio dire», continuò Dupin, nel mentre che io facevo credito, con una risata, a queste sue
ultime osservazioni, «voglio dire che se il ministro fosse stato soltanto un matematico, il prefetto
non si sarebbe trovato nell’alternativa di firmarmi un assegno. Lo conosco, di fatto, per un
matematico e per un poeta nel contempo, ed io avevo prese le mie misure in ragione della sua
capacità, e tenendo conto delle circostanze in cui egli s’era cacciato. Sapevo, così, che egli era un
uomo di Corte e un intrigante rotto alle più spregiudicate macchinazioni. Riflettei che un uomo
simile doveva essere indubbiamente al corrente di tutti i metodi in pratica presso le stazioni di
polizia. Evidentemente egli dovette aver previsto – e gli eventi l’han provato – le imboscate che gli
sono state preparate. Sono sicuro, inoltre, che egli aveva previste anche le perquisizioni a domicilio.
Le sue frequenti assenze notturne, che il nostro bravo prefetto aveva salutate con gioia quali positivi
pronostici del suo successo, io le tenni come dei semplici trucchi per facilitare le libere ricerche
della polizia, e persuaderla, in tal modo, che la lettera non si trovava nell’alloggio. E sentii inoltre
che l’intera serie dei ritrovati relativi alla non mai variata azione poliziesca in tema di perquisizioni –
i medesimi cioè che vi ho ora sciorinati, e dei quali ho cercato, non senza difficoltà, di mostrarvi la
fallacia – sentii, dico, che tutt’intera quella serie aveva dovuto necessariamente dispiegarsi dentro al
cervello del ministro. Tutto ciò doveva imperativamente portarlo a sdegnare qualsiasi sorta di
nascondiglio volgare. Quell’uomo, io credo, non poteva arrivare a tal punto di ingenuità da non
prevedere che il più complicato, il più impensato e profondo nascondiglio della sua casa, non
avrebbe saputo serbare il minimo segreto per le occhiate, i sondaggi, i succhielli e i microscopi del
prefetto. Da ultimo io decisi che egli si sarebbe necessariamente affidato alla semplicità, seppure
non vi dovette essere indotto da un gusto tutt’affatto naturale. Vi rammentate senza dubbio con quali
scoppi di risa il prefetto accolse, durante il nostro primo colloquio, la mia opinione secondo la
quale, se quel mistero lo sconcertava tanto, era solamente a causa della sua assoluta semplicità».
«Infatti», dissi io, «mi ricordo perfettamente la sua ilarità. Credetti sul serio ch’egli fosse per
divenir preda d’un attacco nervoso».
«Il mondo materiale», disse Dupin, «è affatto pieno di sorprendenti analogie con quello
immateriale. Da ciò proviene che i dogmi retorici hanno somiglianza colla verità così come una
metafora o una similitudine possono rendere più persuasiva un’argomentazione al modo stesso che
abbelliscono una descrizione. Il principio della forza d’inerzia ad esempio, sembra aver la stessa
portata nelle due nature, quella fisica e quella metafisica; un corpo d’una certa grandezza è messo in
moto con maggiore difficoltà che non quello d’una grandezza minore, e la sua quantità di
movimento e in proporzione di questa difficoltà. Ed ecco una proposizione analoga altrettanto
incontrovertibile: le intelligenze d’una vasta capacità le quali sono nel contempo più impetuose, più
costanti e più accidentate ne e loro possibilità dinamiche che le altre d’un grado inferiore sono
quelle che si muovono più disagiatamente e che sono le più frastornate d’esitazioni al momento di
mettersi in marcia. Altro esempio: avete mai notato quali siano le insegne di bottega che attraggono
maggiormente la vostra attenzione?».
«Non ci ho mai pensato, a esser sincero», dissi io.
«Esiste», replicò Dupin, «una sorta di indovinello che s’usa giocare su una carta geografica.
Uno dei giocatori prega qualcun altro di indovinare una data parola: il nome d’una città, ad esempio,
d’un fiume, d’uno Stato, d’un impero: una parola qualunque, a farla breve, che sia compresa nella
superficie variopinta e imbrogliata della carta. Una persona che sia nuova al giuoco, cerca, in
generale, di imbarazzare il suo avversario dandogli a indovinare dei nomi scritti in carattere
impercettibile. Ma gli adepti del giuoco scelgono dei nomi scritti a caratteri cubitali, quelli
medesimi che si leggono da un capo all’altro della carta. Quei nomi, come pure quelli delle insegne
e dei manifesti a lettere troppo grandi, sfuggono all’osservatore a causa dello loro stessa evidenza. E
a questo punto dirò che le dimenticanze materiali sono del tutto analoghe alle distrazioni d’ordine
morale di uno spirito che si lascia sfuggire le considerazioni che siano troppo palpabili, fino alla
noia e alla banalità. E questo è un punto, a quel che sembra, un tantino al di sotto, ovvero al di
sopra, dell’intelligenza del prefetto. Egli non ha mai creduto probabile che il ministro avesse
deposta la sua lettera proprio sotto il naso di tutti, nel solo intento d’impedire a un individuo
qualunque di scorgerla. Ma più io mi perdevo a far congetture sull’audacia, la profondità e lo spirito
inventivo del ministro D. – e soprattutto sul fatto ch’egli aveva bisogno di avere il documento
sempre a portata di mano perché potesse usarne tempestivamente, e ancora su quell’altra
circostanza apertamente dimostrata mercé l’aiuto del nostro prefetto, che cioè la lettera non era stata
nascosta in quelli che sono i limiti d’una ordinaria perquisizione foss’anche compiuta a regola d’arte
– e più io mi convincevo che il ministro, per nascondere la sua lettera, era ricorso all’espediente più
ingegnoso che si possa concepire da mente umana, il quale consisteva addirittura nel non tentare
affatto di nasconderla. Forte di questa persuasione, mi aggiustai sul naso un paio d’occhiali verdi e
mi presentai, un bel mattino, con l’aria di capitarvi per puro caso, nell’abitazione del ministro. Il
signor D. era in casa. Egli girandolava per le sue stanze, sbadigliando e gingillandosi con mille
sciocchi argomenti e protestandosi oppresso da una noia mortale. Il ministro D. è, forse, tra i nostri
uomini più energici, ma soltanto quando è certo di non essere osservato da nessuno. Per non esser
da meno di lui, cominciai anch’io a lamentarmi, e accusai un’improvvisa debolezza alla vista che mi
costringeva a portare occhiali verdi. Ma dietro a quelli ispezionavo, con cura e minuzia l’intero
appartamento, badando tuttavia a esser sempre presente alla conversazione del mio ospite.
Concentrai, dapprima, tutta la mia attenzione su una grande scrivania presso la quale egli era
seduto, e sulla quale giacevano, mescolate disordinatamente, alcune lettere ed altre carte, assieme a
qualche volume e uno o due strumenti musicali. Dopo un esame piuttosto prolungato, fatto con tutto
mio agio, non vi scorsi, però, nulla che potesse giustificare i miei sospetti. Ma i miei sguardi, a
lungo andare, dopo aver fatto un completo ed accurato giro della camera, caddero su un qualsiasi
portacarte adorno di lustrini, e sospeso a mezzo d’un nastro scolorito a un piccolo bottone di metallo
dorato proprio al centro della cappa d’un caminetto. Quel portacarte era diviso in tre o quattro
compartimenti, e lasciava vedere, oltre a cinque o sei piccoli biglietti da visita, una lettera. Questa
era piuttosto sudicia e spiegazzata. Ed era come divisa in due pezzi da uno strappo nel mezzo, il
quale denotava l’intenzione, in un primo momento, di stracciarla come se si trattasse d’un oggetto di
nessun valore. Essa recava un largo sigillo nero colla cifra D., bene evidente, ed era indirizzata allo
stesso ministro. L’indirizzo era stato tracciato da mano femminile, con una calligrafia molto sottile
ed elegante. Era stata gettata negligentemente, ed anche, a quanto sembrava, con un certo sdegno, in
uno degli scomparti superiori del portacarte. Fin dal primo colpo d’occhio, ch’io posai su quella
lettera, non ebbi alcun dubbio che fosse proprio quella che stavo cercando. Essa era, nell’aspetto
esteriore, del tutto differente da quella di cui il prefetto ci aveva letta una tanto minuta descrizione.
In questa del portacarte, il sigillo era largo, nero e recava la lettera D., mentre in quella descritta nel
promemoria del prefetto, il sigillo era piccolo e rosso, con sopra lo stemma ducale della famiglia S.
In questa l’indirizzo era di mano femminile, in quella l’indirizzo – d’un personaggio regale – era stato
tracciato da una mano ardita e decisa. Le due lettere non si rassomigliavano, insomma, che in un sol
punto: nella dimensione.
Ma lo stesso carattere d’esagerazione di quelle differenze, fondamentali,
insomma, – la sudiceria, lo stato deplorevole della carta, spiegazzata e lacerata, in perfetto contrasto
con le abitudini, invece, del ministro, universalmente noto per il suo ordine e la sua metodicità – di
quelle differenze che denunciavano chiaramente l’intenzione di sviare un’indagine indiscreta
offrendo tutta l’apparenza d’un documento senza valore – tutto questo, coll’aggiunta della impudente
ostentazione del documento messo addirittura in mostra perché lo potesse veder bene chiunque
fosse passato nella stanza, la quale ostentazione si trovava a esser pienamente d’accordo con le mie
conclusioni suesposte – tutto questo, mi dissi, è combinato in tal modo da corroborare i sospetti di
qualcuno venuto, appunto, col partito preso d’un sospetto. Prolungai la mia visita il più possibile, e
nel mentre che sostenevo una vivacissima discussione col ministro, su un argomento che conoscevo
per essergli sempre gradito, non distraevo la mia attenzione dalla lettera. Nel corso di quell’esame,
mi posi a riflettere sul suo aspetto esteriore e sul modo nel quale era stata collocata nel portacarte,
fintanto che non pervenni a una scoperta, la quale disperse pure l’ultimo impercettibile dubbio che
poteva essermi rimasto. Osservando i bordi della carta, notai che essi erano più logorati che non
comportasse un uso naturale. Infatti, presentavano le caratteristiche di logorio d’un cartoncino che
sia stato ripiegato nel senso inverso, ma lungo la medesima piegatura. Questa scoperta mi era più
che sufficiente.
Era chiaro che la lettera era stata rovesciata, come un guanto, ripiegata e
nuovamente sigillata. Augurai il buon giorno al ministro e presi congedo da lui, non senza aver
dimenticata, a bella posta, una tabacchiera d’oro sul suo tavolo. Il mattino di poi tornai a cercar la
tabacchiera, e colsi l’occasione per riprendere, vivacissimamente anche stavolta, la conversazione
del giorno innanzi. Ma nel mentre che la discussione era al massimo del suo interesse, una
detonazione fortissima, come una revolverata, si fece sentire sotto alle finestre della casa, ben presto
seguita dalle urla e dalle vociferazioni d’una folla spaurita. Il ministro D. si precipitò a una finestra,
l’aprì e si sporse a guardare al basso. Nello stesso istante io filai diritto al portacarte, presi la lettera,
l’intascai e la sostituii con un’altra, una sorta di fac-simile – quanto all’apparenza esteriore – che
avevo preparato con cura, a casa, contraffacendo la lettera D. del sigillo con un mollica di pane. Il
tumulto nella strada era stato motivato dal capriccio inconsulto d’un individuo armato di fucile. Egli
aveva scaricata la sua arma davanti a una folla di donne e di bimbi. Ma poiché essa era caricata
soltanto a salve, quell’originale fu lasciato continuare il suo cammino, una volta riconosciuto per
innocuo, e il suo gesto fu attribuito ad avere egli alzato il gomito. Quando fu partito, il ministro D.
si ritirò dalla finestra dove io l’avevo immediatamente seguito dopo essermi assicurata la preziosa
lettera. Pochi istanti appresso mi congedavo nuovamente. Il preteso pazzo della sparatoria era stato
pagato da me per far quella parte».
«Ma qual è lo scopo», domandai io, «che vi ha indotto a sostituire la lettera con una sua
contraffazione? Non sarebbe stato più semplice, fin dalla vostra prima visita, d’impadronirvi della
lettera, senza altre precauzioni, e di filare?».
«Il ministro D.», replicò Dupin, «è capace di tutto, ed è un uomo dai nervi a posto. Inoltre
dispone, nel suo stesso alloggio, checché ne dica il prefetto, di servi devotissimi. Se io avessi osato
attuare lo stravagante tentativo cui avete accennato, non sarei uscito vivo dalla sua casa. I buoni
parigini non avrebbero più sentito parlare di me. Ma, a parte queste considerazioni, avevo una mira
particolare. Voi siete a parte delle mie simpatie politiche. In tale affare io ho la parte del partigiano
della dama in questione. Sono diciotto mesi che il ministro la tiene in suo pugno. Ed essa è, per
contro, ora a tener lui, dal momento che egli ignora che la lettera non è più a casa sua ed è sempre
sulle mosse di ricattare. Egli, dunque, andrà incontro, da se stesso, alla sua rovina politica, e in un
colpo solo. La sua caduta non sarà meno precipitosa che ridicola. Si parla con molta sicumera di un
facilis descensus Averni, e nondimeno, in materia di scalate, si può ripetere ciò che Catalani diceva
a proposito del canto: è più facile salire che discendere. Nel caso presente, io non ho veruna
simpatia, inclinazione, o pietà, per colui che sta per discendere. Il ministro D. è il vero monstrum
orrendum, un uomo di genio senza alcun principio. Vi confesso tuttavia che non mi dispiacerebbe
affatto di conoscere l’esatta natura dei suoi pensieri, al momento in cui, sfidato da quella che il
nostro prefetto chiama una certa persona, egli sarà costretto ad aprire la lettera che io ho lasciato,
per lui, nel suo portacarte».
«Come? Gli ci avete messo, forse, qualcosa di particolare?».
«Ah, no! Mi sarebbe apparso affatto sconveniente lasciargli l’interno in bianco. Avrebbe
avuta l’aria d’un insulto. Una volta, a Vienna, il ministro D. mi ha giocato un brutto tiro, ed io gli
dissi, in quell’occasione, e in tono tutt’altro che di scherzo, che me ne sarei ricordato. Per modo che,
prevedendo la sua curiosità relativa alla persona che l’ha gabbato, ho pensato che sarebbe stato un
vero peccato di privarlo d’un qualunque indizio. Egli conosce benissimo la mia calligrafia, ed io ho
copiato, proprio in mezzo alla candida pagina, questi versi:
Un dessein si funeste
S’il n’est digne d’Atrèe, est digne de Thyeste.
Li troverete nell’Atrée di Crebillon».
F i n e
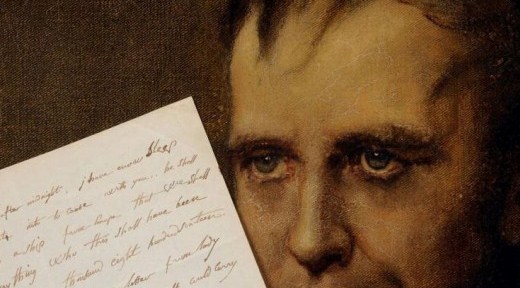






Johnf214
6 Maggio 2016 @ 15:36
Hey esto es un gran poste. Puedo utilizar una porcin en ella en mi sitio? Por supuesto ligara a su sitio as que la gente podra leer el artculo completo si ella quiso a. Agradece cualquier manera.
Dalla Redazione
8 Maggio 2016 @ 15:02
si puedes obviamente citandonos
grazias Giulia D.B.
Luciano donatelli
29 Agosto 2016 @ 21:03
È un grande trattato di marketing e di analisi comportamentale dell’essere umano. Senza tempo e senza fine
Dalla Redazione
30 Agosto 2016 @ 05:59
Si, non dimentichiamo che Poe aveva studiato le dinamiche psichiche e in quel periodo si iniziava a parlare di skotoma, inteso come annullamento psichico di una realtà fisica esistente. Purtroppo poi intervenne Freud con la sua “rimozione” che affossò questa ricerca in fieri che doveva portare, dopo un secolo, alla scoperta della “pulsione di annullamento” che “fa sparire” anche la reltà psichica dell’altro da sé, reificando la realtà umana.
Giulia D. B. per la Redazione di G&N